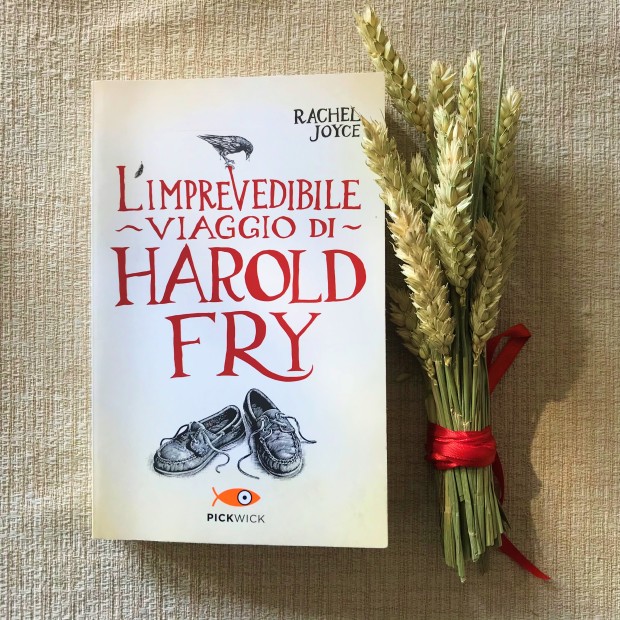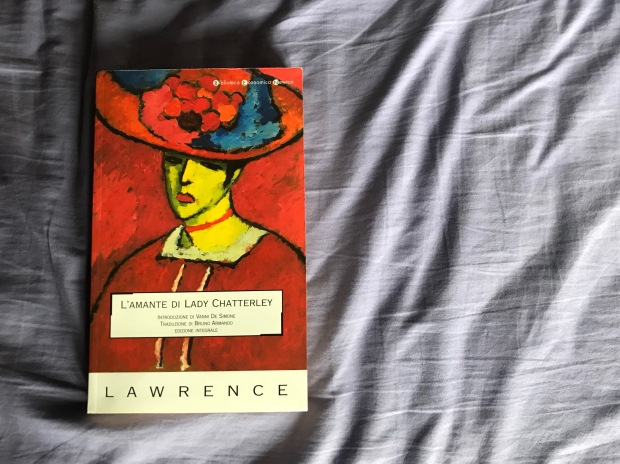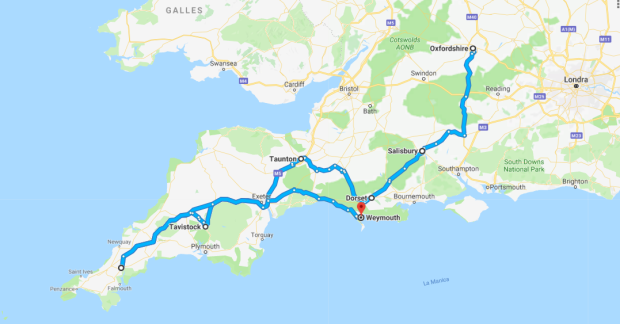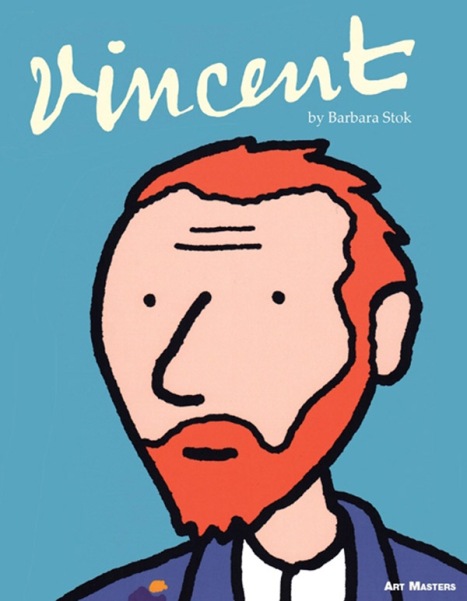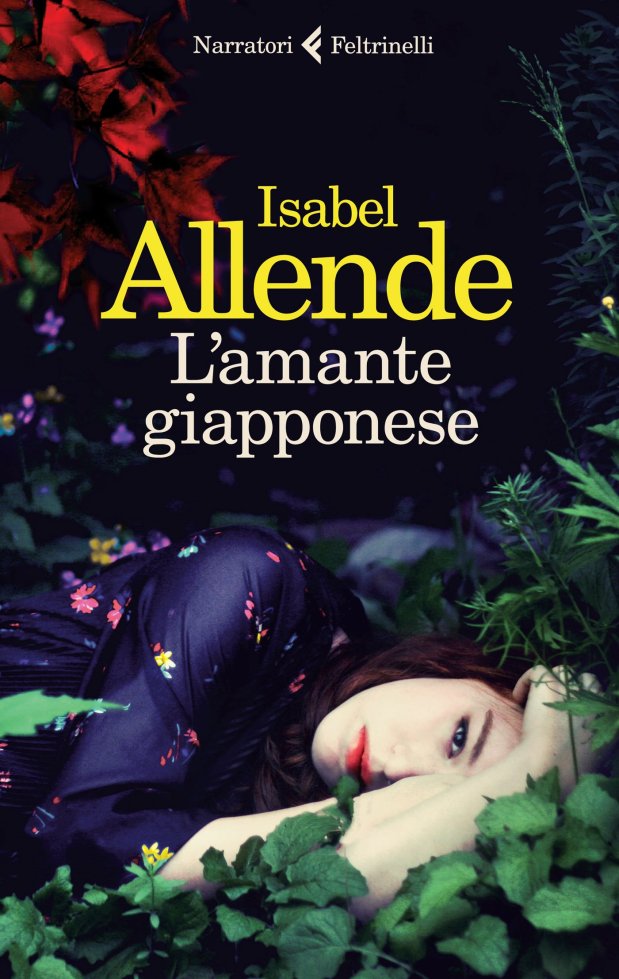Dal basso verso l’alto: I racconti del treno, D. Billitteri / Il bar sotto il mare, S. Benni / L’inventore di sogni, I. McEwan / Il meglio dei racconti, D. Buzzati / Gli amori difficili, I. Calvino
Spesso nel Club si è discusso se siano meglio i romanzi, soprattutto quelli molto lunghi e corposi, o i racconti. La preferenza è andata sempre per i primi rispecchiando quelli che sono i gusti di tanti lettori italiani. Insomma, in Italia il racconto non piace molto e non vende. Ma perché?
Mentre stavo riflettendo su questa domanda prima di incominciare a redigere l’articolo, mi sono imbattuta, con stupore, in un racconto di D.F. Wallace dal titolo È tutto verde, nella raccolta di racconti La ragazza con i capelli strani, di ben sole due pagine.
E in due sole pagine, con abilità di sintesi e rapidità (la “rapidità” che ci richiama alla seconda lezione americana di Calvino), riusciamo ad entrare nel mondo di Mitch e Mayfly e della loro crisi di coppia, che forse crisi non è, ma il protagonista la percepisce come tale e ce ne parla.
E le ho qui le due pagine. Qui mentre scrivo. Le ho fotocopiate. E le leggo e le rileggo per carpirne il segreto. Perché un racconto necessita di una tecnica di scrittura che sappia raccontare tanto e bene in poche righe. Vetta eccelsa della sintesi dove il racconto breve gareggia solo con la poesia.
Il racconto, è bene sapere, mette a dura prova la bravura del vero scrittore. Diceva W. Faulkner: «Ogni romanziere, all’inizio, vuole scrivere poesie e, non riuscendoci, prova con i racconti, che sono la forma letteraria più difficile dopo la poesia. Poi, fallendo anche con quelli, l’unica cosa che gli resta da fare è mettersi a scrivere un romanzo». E capiamo che non è cosa facile, anche se con ironia.
Forse il racconto non piace perché raramente è descrittivo, lascia a noi l’immaginazione e lo sforzo di capire e vedere la storia narrata. Dice Calvino a proposito di un racconto su Carlomagno ormai anziano: « […] ma io trovo molto più forte la suggestione dello scarno riassunto, dove tutto è lasciato all’immaginazione e la rapidità della successione dei fatti dà un senso d’ineluttabile […]».
O, invece, a noi italiani non piace la storia breve perché siamo noi stessi prolissi, enfatici, oserei dire, cinematografici nel pensiero e teatrali nelle discussioni. Il romanzo viene quindi a compensare questo nostro desiderio di pieno, di colmo, di straripante. Ma questa è solo una mia ipotesi che non fa testo.
E mi rifugio di nuovo in Calvino: «La concisione è solo un aspetto del tema che volevo trattare, e mi limiterò a dirvi che sogno immense cosmologie, saghe ed epopee racchiuse nelle dimensioni d’un epigramma. Nei tempi sempre più congestionati che ci attendono, il bisogno di letteratura dovrà puntare sulla massima concentrazione della poesia e del pensiero».
Ma allora questa forma letteraria ci piace o no? Ho voluto sentire, come ormai consuetudine,
gli amici del Club che sono sempre scrigni preziosi di idee e intuizioni.
Ecco cosa dicono.
Rossella V. :«Mi piacciono abbastanza! Anche se in genere preferisco la complessità dei romanzi. Una raccolta di racconti che mi viene subito in mente di aver letto è “Gente di Dublino” di James Joyce. Ce ne sono due che mi sono piaciuti tantissimo (per la cronaca, “Arabia” e quello dell’uomo solitario)».
Simona B. :«Io non sono una amante di questo tipo di lettura, anche se i racconti della Munro mi hanno aiutato a rivalutarli».
Fulvia G. :«Non amo i racconti. Non mi danno il tempo di “affezionarmi” alla lettura».
Cristina P. :«Io invece li amo moltissimo come genere ma devono essere ben scritti».
Alessandra O.B. :«I racconti di Emmanuel Schmitt, ad esempio! Adoro i racconti e le novelle! Folgorazioni impressionistiche!».
Elisa B. :«Ho un rapporto di amore-odio nei confronti dei racconti, mi spiego: sin da piccola ho sviluppato una forte passione per i lunghi e prolissi romanzi, ma alle superiori, conoscendo per la prima volta Buzzati, ho scoperto il potere evocativo dei “veri” racconti, quelli scritti da scrittori di un certo calibro. Ecco, direi che mentre un romanzo talvolta può appassionarmi e coinvolgermi nonostante qualche pecca dal punto di vista stilistico o narrativo, da un racconto io “esigo” sempre che sia “perfetto”. E allora sì, in questo caso mi piacciono i racconti».
Stefania T. :«Io li amo sopra ogni cosa: il racconto è il tipo di narrativa che preferisco in assoluto. Il mio pensiero è un po’ ingarbugliato e traballante, spero di riuscire ad esprimerlo bene: in genere avverto nei romanzi il tentativo di raccontare una storia nella sua compiutezza, di dare quindi una visione compiuta e finita della vita, di una vita (come un cerchio che si chiude). Mentre nel racconto di solito trovo la descrizione di un frammento, di un momento, come una fotografia. Il romanzo mi sembra spesso proiettato a spiegare, mentre il racconto a fermare su carta, con le parole, un istante. Naturalmente il discorso non vale per tutti i romanzi e per tutti i racconti: ci sono moltissimi romanzi moderni o sperimentali, e moltissimi racconti che raccontano storie dal principio alla fine. “La signora Dalloway” è considerato un romanzo, ad esempio, eppure risponde perfettamente alla mia personale idea di letteratura. E ci sono tanti scrittori di racconti che scelgono di tentare di raccontare “tutto” ogni volta. Ma queste sono secondo me zone periferiche rispetto alla norma. Per queste ragioni, e quindi perché non credo che l’uomo possa essere un narratore che gestisce le redini di qualcosa e che tutto comprende (quando si cimenta in questo ruolo secondo me la letteratura, anche se bellissima, è sempre artificio), preferisco il racconto. Quando è frammento di vita. Per fare degli esempi concreti: Anna Karenina (che ho amato moltissimo) come romanzo, Carver come scrittore di racconti».
Marcello P. :«Mi piacciono, ho letto ed ho tutti i racconti e novelle di Maupassant; sono immediati, con tre pagine ti scorrono vite incredibili e indicibili; naturalmente scritti in modo impeccabile».
Silvia O. :«In passato ho sempre sottovalutato i racconti, li utilizzavo perlopiù per approfondire gli autori perché, di per sé, sentivo come se non mi permettessero di entrare nel cuore di ciò che stavo leggendo, di non creare un tutt’uno tra me e la lettura. Nei tempi più recenti li sto rivalutando parecchio e anzi, spesso li trovo più brillanti e profondi: in poco tempo e in poche pagine mi fanno assaporare tutta l’essenza di un autore!».
Stefania L.R. :«Ho amato i racconti, soprattutto durante l’adolescenza, e adesso mi piacciono perché mi consentono di leggere anche quando ho meno tempo da dedicare alla lettura».
Catia B. :«Come Fulvia e Simona, anche io non sono un’amante dei racconti. Anche se ho adorato le Novelle di Maupassant. Uno dei miei romanzi preferiti, e per me uno dei più belli in assoluto, è La fiera delle vanità di William Thackeray che con le sue 885 pagine è proprio l’opposto del racconto. Però col fatto che spesso si ha poco tempo per leggere un bel racconto spaventa di meno e può essere egualmente arricchente».
Riccardo S. :«Allora, non è che sia io un gran lettore, ho iniziato da molto poco e non faccio poca fatica, specialmente per i libri lunghi. Sono molto attirato dai racconti, ne ho letti anche alcuni e devo dire che, per quello che mi riguarda, la lunghezza del racconto è il suo punto forte; l’essere conciso da poter essere letto tutto d’un fiato è un qualcosa che a me piace tanto. Appena avrò tempo leggerò i racconti di Hemingway (magari sotto l’ombrellone) ma per fare un esempio di racconti che mi sono piaciuti fin dalle superiori devo citare Pirandello, con le novelle».
Insomma che dire? È stata una discussione arricchente con tanti apporti e motivi di riflessione. Certo che, per le nostre spesso concitate discussioni, i racconti le frazionerebbero e ci sarebbe un po’ di dispersione nella condivisione.
E io? Li amo. E, rubando il pensiero a Calvino, «vorrei qui spezzare una lancia in favore della ricchezza delle forme brevi, con ciò che esse presuppongono come stile e come densità di contenuti».
Pia Deidda